That Old Weird America
Una contro-narrazione dell’America
“La musica tradizionale si basa sugli esagrammi. Nasce da leggende, Bibbie, pestilenze, e ruota intorno alle verdure e alla morte. Nessuno ucciderà la musica tradizionale. Tutte queste canzoni sui fiori che crescono dai cervelli delle persone e sugli amanti che in realtà sono oche e cigni che si trasformano in angeli – non moriranno. Sono tutte quelle persone paranoiche che pensano che qualcuno verrà a portargli via la carta igienica – sono loro che moriranno. Canzoni come “Which Side Are You On?” e “I Love You, Porgy” – non sono canzoni di musica popolare; sono canzoni politiche. Sono già morte. Ovviamente, la morte non è molto universalmente accettata. Voglio dire, si penserebbe che gli amanti della musica tradizionale potrebbero capire, dalle loro stesse canzoni, che il mistero – un semplice, puro mistero – è un fatto, un fatto tradizionale. Ascolto le vecchie ballate; ma non andrei a una festa ad ascoltare le vecchie ballate. Potrei descriverti in dettaglio l’effetto che hanno su di me, ma alcune persone probabilmente penserebbero che la mia immaginazione sia impazzita. Mi fa ridere che la gente abbia davvero la faccia tosta di pensare che io abbia una sorta di immaginazione fantastica. È una cosa molto solitaria. Ma comunque, la musica tradizionale è troppo irreale per morire. Non ha bisogno di essere protetta. Nessuno la ferirà. In quella musica c’è l’unica vera, autentica morte che oggi puoi sentire uscire da un giradischi. Ma come tutto ciò che è molto richiesto, la gente cerca di possederla. Ha a che fare con una questione di purezza. Penso che il suo non significare nulla sia sacro”
- Bob Dylan 1966
Il concetto di mistero sottintende alla vita della singola persona ma anche di una intera nazione. Il mistero significa che non puoi possedere le cose, gli altri, te stesso, il tuo paese. È per questo che l’epoca moderna sta uccidendo il concetto di mistero, Lo sta facendo Donald Trump, riducendo gli Stati Uniti d’America, contenitori di mistero, a un deserto piatto, monolitico, privo di ogni significato. Lo sta facendo Elon Musk allo stesso modo. Viviamo in un tempo in cui l’immaginario collettivo è colonizzato da uomini che si presentano come visionari o salvatori, ma che in realtà sembrano incarnare l’avidità, la disconnessione e il culto del sé. Personaggi come Musk e Trump non sono solo individui potenti: sono simboli. Simboli di una società che ha scambiato la comunità con l’efficienza, la verità con lo spettacolo, la solidarietà con il profitto.
La loro ascesa ha lasciato dietro di sé una scia di solitudine diffusa, dove le persone si ritrovano più isolate che mai in un mondo iperconnesso. Promettono libertà, ma la riducono a consumo. Parlano di futuro, ma lo rendono proprietà privata. Il loro cinismo è contagioso: l’idea che tutto sia negoziabile, persino la dignità umana, è diventata una moneta corrente.
La perdita più profonda è quella del mistero. Tutto dev’essere spiegato, svelato, semplificato, monetizzato. Non c’è più spazio per ciò che non si capisce, non si controlla, non si compra. Il mistero – che un tempo dava senso alla poesia, alla religione, all’amore e persino alla morte – è stato cacciato via dal linguaggio della tecnica e del calcolo. Non ci si inchina più davanti all’inconoscibile, lo si disprezza. L’incertezza non è più una condizione dell’esistenza, ma un bug da correggere.
È il 13 febbraio 2011 quando, come uno spettro nell’oscurità, Bob Dylan fa capolino sul palcoscenico dei 53esimi Grammy Awards allo Staples Center di Los Angeles. Il cantautore si esibisce in Maggie’s Farm, paradossalmente la canzone che aveva scritto per dire addio alla scena folk e tradizionale. Ad accompagnarlo la nuova generazione che sta recuperando la musica tradizionale anglo-americana, i Mumford & Sons e gli Avett Brothers. È come il passaggio della torcia dal grande vate ai giovani.
In quel periodo storico, tra la fine degli anni zero e i primi anni dieci del 2000, accade qualcosa di unico e portentoso. Tanti ragazzi invece di adattarsi all’elettronica, il trap, la rap, o chitarre assordanti, recuperano vecchi strumenti acustici. E cercano un significato nel mistero della musica tradizionale. Si rimettono a cercare il territorio della Repubblica Invisibile che Bob Dylan aveva già varcato decenni prima.
Il legame tra l’opera dei Fleet Foxes, dei Decemberists (ma anche My Morning Jackett, Son Volt e tanti altri) e ciò che fece Bob Dylan con The Basement Tapes è profondo e strutturale. Non si tratta solo di una somiglianza estetica o musicale, ma di una comune tensione verso la riscoperta di un’America parallela, mitica e sepolta sotto la superficie del presente — quella che lo scrittore e critico musicale Greil Marcus definì The Old, Weird America, ovvero l’America strana, antica e invisibile.
Nel 1967, dopo un misterioso incidente in moto, Dylan si ritira nella campagna di Woodstock, nello stato di New York. Lì, nel seminterrato di una casa chiamata Big Pink, insieme alla sua band (che diventerà poi The Band), registra dozzine di canzoni mai pensate per il mercato, lontane dal folk revival politicizzato e dalle luci del mondo. Quelle registrazioni sono piene di spiritua, murder ballad, nonsense, canti rurali, accenti biblici e linguaggi dimenticati. È un Dylan che abbandona la figura del profeta urbano e si trasforma in un medium della tradizione orale americana, attingendo a un folklore oscuro e carnale.
Secondo Marcus, Dylan in quel momento “entra nella repubblica invisibile”: un’America che non compare nei manuali di storia, ma vive nei racconti dei vagabondi, nei sermoni dei predicatori itineranti, nei canti delle prigioni e nelle fiabe dei coloni. Questa Old Weird America è una terra di fantasmi, paradossi e visioni. Non è nostalgia: è un'esplorazione mitopoietica del profondo.
Proprio in questa repubblica invisibile si muovono, decenni dopo, i Fleet Foxes e i Decemberists. I primi lo fanno con una spiritualità pastorale e contemplativa. Ascoltando brani come The Shrine / An Argument o Ragged Wood, si ha la sensazione di percorrere sentieri di una natura arcaica, dove l’anima americana si dissolve nel paesaggio e nel tempo circolare delle stagioni. È una musica che rifiuta l’urbano, il moderno, il chiasso mediatico, proprio come Dylan nei Basement Tapes. Anche i testi di Robin Pecknold, il frontman, spesso parlano per immagini, con versi che sembrano tratti da antiche ballate o visioni oniriche — forme di sapienza antica travestite da confessione personale.
I Decemberists, invece, calcano con più decisione il sentiero narrativo tracciato dalle murder ballads e dalle broadsides (le canzoni stampate su volantini del XIX secolo). Album come The Hazards of Love non solo si ispirano all’estetica del folklore gotico, ma la rimettono in scena con una teatralità da cantastorie rinascimentale. Come Dylan, anche Colin Meloy crea personaggi fuori dal tempo, creature che sembrano venire da una tradizione orale immaginaria, ma terribilmente reale nei suoi archetipi.
Dylan, nei Basement Tapes, suggeriva che esistesse un’America altra, fatta di simboli, miti e strutture arcaiche che la modernità aveva cercato di cancellare. I Fleet Foxes e i Decemberists riprendono e aggiornano questa visione, diventando cantori di una storia non ufficiale, fatta di dolore, magia, ambiguità e salvezza possibile solo nel ritorno al mistero.
Come Dylan, rifiutano la linearità del progresso, preferendo il labirinto del mito. Come Dylan, scelgono il suono del legno, della voce naturale, degli strumenti acustici e della parola evocativa, capace di farsi allegoria.
In questo senso, l’opera dei Fleet Foxes e dei Decemberists non è semplicemente un omaggio alla tradizione: è una continuazione del viaggio iniziato da Dylan nel seminterrato di Big Pink. È la prosecuzione della costruzione — mai terminata — di una repubblica invisibile, dove la musica è rito, racconto e visione. Dove l’America non è un luogo, ma un sogno antico, inquieto, strano — e bellissimo.
Il gotico americano — spesso associato a vecchie piantagioni del Sud, a racconti di fantasmi e stranezze quotidiane — è un genere che si nutre di paesaggi e silenzi, di superstizioni e di memorie sussurrate. È questo lo sfondo emotivo che emerge nei dischi dei Fleet Foxes, soprattutto in capolavori come Helplessness Blues e Crack-Up, dove il suono delle armonie vocali si mescola con strumenti acustici, richiami pastorali e testi dal sapore arcaico. I loro brani sembrano provenire da una foresta senza tempo, un luogo liminale in cui l’anima del folk incontra la profondità della riflessione esistenziale. C’è qualcosa di sacrale, ma anche di inquietante, come nei racconti di Flannery O’Connor o nei dipinti di Andrew Wyeth: bellezza e turbamento convivono.
I Decemberists, invece, mettono in scena veri e propri drammi in musica. Il loro gotico è teatrale, letterario, fatto di ballate epiche e storie di omicidi, naufragi, fantasmi e amanti sfortunati. Album come What a wonderful work what a terrible world o Picaresque sembrano concept album partoriti in una biblioteca vittoriana ma ambientati nei sobborghi e nei boschi dell’America più profonda. Colin Meloy, voce e penna della band, scrive testi che evocano lo spirito di Edgar Allan Poe o delle ballate murder folk tradizionali, recuperando una narrazione lirica che sfida i canoni del pop contemporaneo. È musica che invita all’ascolto attento, come se ogni canzone fosse un capitolo di un romanzo gotico.
Fleet Foxes e Decemberists non sono nostalgici: sono custodi e innovatori. Non imitano la tradizione americana — la reinventano, la reinterpretano, la vestono di nuove ansie e nuovi sogni. In un’epoca disincantata, riportano in vita una forma di sacralità musicale che si nutre di paesaggi interiori, di storie non raccontate, di un’America mitica e al tempo stesso reale. È una tradizione che parla non solo del passato, ma del bisogno contemporaneo di radici, di mistero, di lentezza.
Questa riscoperta della tradizione americana, con i suoi accenti gotici, non è solo musicale: è culturale. È la riscoperta di un’identità profonda, che sfugge al clamore e trova forza nella terra, nei miti, nella memoria e nella musica.
In un tempo dominato dalla velocità e dall’elettronica, la musica folk americana sembra un richiamo da un altro mondo, un'eco di boschi antichi, di leggende mai sopite e di racconti tramandati sotto il portico di una casa in legno, al tramonto.
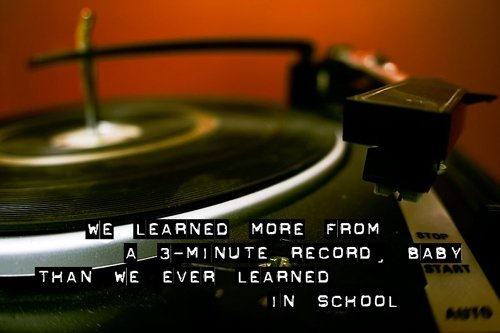














Commenti